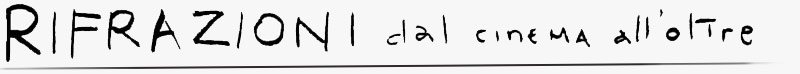
|
MAN IN THE BOX
su The
Box (2009, di Richard Kelly)
di MAURIZIO INCHINGOLI
Magia.
Parola adatta a spiegare la sensazione avuta appena visto i primi frames di un
lavoro che sorprende. Per anacronismo, per bellezza figurativa, per ricerca
iconografica e scenografica che ricorda davvero il cinema di un tempo che fu.
Richard
Kelly è un film-maker che sfida il tempo, lo fa suo, lo piega con forza per le
sue ardite sperimentazioni sulla psiche umana. Ci immortala come esseri
soppiantati da tanta, spropositata e violenta furia tecnologica. Ci mette
illusoriamente davanti al mis-fatto compiuto. Con un coraggio autorale della
migliore fattura, ripescando un autore – il Richard Matheson di Button
Button (1970)
– evergreen della
scrittura di science-fiction da ricordi di uraniana memoria. Lasciando
finalmente in disparte il troppo saccheggiato Philip K. Dick, e provando a dare
una potente chiave di lettura in forma di pamphlet visivo-sonoro affascinante e
mostruoso. Con una modalità di ripresa degli spazi che evoca un certo Fritz
Lang osava fare, e con una cura certosina dei particolari – come ad
esempio nell’uso delle luci, di un’accecante bellezza – che di certo
Stanley Kubrick avrebbe apprezzato.
Tutti
modelli che il regista della Virginia sembra conoscere a menadito, in una
convincente costruzione-scatola che si fa sensoriale prova di forza per i
nostri palati rovinati da visioni a volte troppo fast & furious, tali da farci quasi dimenticare
la magia del cinema stesso. Che deve saper ri-costruire mondi, possibilità, e
varcare soglie, oltre regole e convenzioni abusate e già ampiamente codificate.
In una rilettura altamente invasiva, potentemente visionaria e provocatoria che
ci lascia, in questo caso, quasi esterrefatti.
Costruire
mondi dicevamo, come soprattutto il David Lynch di INLAND EMPIRE (2006) è riuscito a fare, in
quella serie di scatole cinesi nere e sord(id)e che provavano a sondare
l’incoscio post-umano e fuori dal tempo concesso a loro. Kelly prova invece a
costruire mondi nel tempo e nella Storia, prova a rileggere il passato con la
consapevolezza che non si può ri-codificare il tutto senza aver prima provato a
forzare il ricordo, e mettere alla prova la memoria visiva e sensoriale
dell’essere umano-attore-animale. Operazione ardua e complessa, foriera di
enormi fraintendimenti. Ciò che avviene, ed è già passato, serve a Kelly per
ricostruire un tessuto mnemonico, una texture forata da mille punte d’acciaio
che sono lì, pronte a bucare quella memoria, pronte ad alimentare il
dimenticatoio che si fa beffe quasi della magia delle immagini. Magia che invece
ritroviamo felice e per niente consolatoria in una storia ambientata nel 1979,
con una scatola di legno e un bottone muti come protagonisti, pronti a far
esplodere la conseguenza temporanea e a far da scacco tra i corpi. In uno
scarto negato che stimola riflessioni e paranoie post-adolescenziali da letture
fatte di notte, al lume di candela, prendendo di mira autori ‘problematici’
come Jean Paul Sartre, citato esplicitamente nel film come fosse la vera pietra
di scambio tra la co(no)scienza oggettiva dell’uomo e la sua proiezione
riflessiva e riflettente. Un concetto, una prova d’autore, e un viaggio
all’interno della mente, in quel buio cerebrale che fa venire voglia allo
spettatore di mettere sotto sforzo le meningi. Di mettersi sostanzialmente a
dura prova, in un esercizio coercitivo anche vagamente sadico. The Box come un esperimento riuscito di
forzatura sulle teste e sui corpi di questi attori con quelle facce cosi anni
’50 che sembrano uscite da un film di Don Siegel – ci vengono in mente, a
questo proposito, le paurose immagini de L’invasione degli ultracorpi (Invasion of the Body
Snatchers, 1956)
–, che pongono diverse riflessioni sul rapporto tra la paura e l’uomo e
la sua maschera. Cosi ben materializzate nella faccia cadaverica dello studente
che provoca la protagonista femminile (ancora più inquietante nella scena della
festa vestito da cameriere), dove sembra di rivedere la proiezione anonima e
molto ’70s di Jake Gyllenhaal/Donnie Darko. Se quel film impostava le sue
fisime visive sugli anni ’80, questo fa un piccolo passo indietro, agli albori
di quel decennio che stava per nascere, che Kelly evidentemente deve avere
amato/odiato fino allo spasimo. E si fa accompagnare, in questo triste viaggio
tra tecnologia e scatole di legno “amare”, da una serie di songs languide e
quasi soporifere, ma perfettamente in sintonia con la pellicola. Svetta –
tra lacerti ambigui di Grateful Dead, Pat Boone e Wilson Pickett – la When
Joanna Loved Me di Scott Walker, yankee-crooner “maledetto” ritiratosi poi a vita privata in Gran
Bretagna per scrivere in sordina albums davvero fuori fuoco e “sartriani”
nell’anima come “Tilt” e “The Drift”. Lavori, questi, colmi di livore e di riflessioni post-umane già
presenti in vitro nei pezzi della sua fase (“pre-mestruale”) di presa di
coscienza, tra cui il pezzo in questione. Lo score del film è poi un profluvio di
archi “trattati” a dovere che alimentano un coacervo di ambientazioni sinistre,
e che fanno il verso alle migliori e vertiginose partiture di gente come
Bernard Herrmann e John Barry, senza dimenticarsi che quegli archi servono a
sottolineare una o più scene decisive di questo piccolo film fluviale. Il fatto
è che Kelly deve aver trovato il suo compositore preferito tra i cd della sua,
immaginiamo, sterminata discografia casalinga, ed è andato a ingaggiare un enfant
prodige della
scrittura per archi anche in forma popular. Il suo nome è Owen Pallett e, i più
attenti, avranno incrociato le gesta artistiche di questo canadese in dischi
indie e misconosciuti come “He Poos Clouds” – titolo alquanto bizzarro e
strepitoso con il primo monicker, Final Fantasy – e l’ultimo, a nome
proprio, “Heartland”. Tutti
lavori dal forte appeal cinematografico, in particolare l’ultimo, dove sembra
di sentire una versione anfetaminica e “altezzosa” di certe partiture di Danny
Elfman, quello del Beetlejuice (1988) di Tim Burton, tanto per intenderci. Un connubio
che sottolinea in modo decisivo alcune delle scene più belle di questo film
mesmerico e magicamente aggrappato al sogno di una vita più agiata che mai
potrà essere completamente soddisfatta. E queste possenti e invasive note
febbrili servono ad accompagnarci in un incubo-sogno dal quale facciamo una
certa fatica a risvegliarci, tant’è stata la sua persuasione sensoriale sulle
nostre meningi, che apprezzano decisamente questo aeriforme e colorato box in
forma di immagini che contiene una quantità enorme di materiale sulla quale
discettare: il futuro, il passato, la cognizione stessa del tempo, la
percezione del ricordo, la dimensione magica del sogno, tutte cose che vanno di
pari passo col suono degli archi, con le facce “perplesse” e “anonime” dei suoi
attori, con l’idea di un regista coraggioso, e con il nostro sguardo, che
approva e sorride felice di fronte a tanta positiva e salutare boccata d’aria
fresca. Racchiusa in una scatola alla quale non daresti nessun valore
apparente, che però nasconde in sé, e sprigiona poi, un oggetto misterioso per
antonomasia: l’uomo. Prendere o lasciare…
|
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -