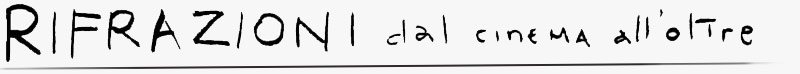
|
A
PROPOSITO DI NIENTE DA NASCONDERE
su Caché (2005, di Michael Haneke)
di
SANDRO SPROCCATI
Cominciamo dalla fine. Nella sua
tendenza alla mimesi del romanzo moderno, il classico prodotto del cinema
– in quanto testo
narrativo – prevede lo scioglimento della vicenda rappresentata come un luogo pressoché
ineludibile. Il senso globale dell’opera fonde e coagula, sempre, in tale apice conclusivo (il botto finale) che collabora a
definire lo statuto etico, oltre che linguistico, della narrazione
cinematografica. Un luogo, quello dell’epilogo, dove i nodi vengono
proverbialmente al pettine, e proprio per ciò del tutto sconosciuto alla vita
reale: coincidente con il lieto-fine, insomma, o con una fine che sarà lieta anche quando essa fosse per
avventura – ossia per scelta etico-ideologica – tragica e
sconsolante: un luogo, infine, che la parola stessa “Fine”, “The End”, segna
tutte le volte (anche se fosse furbescamente omessa) a suggello della
completezza del messaggio imposto allo spettatore: la cui accezione, dico del
termine “messaggio”, ma anche del termine “Fine”, scivola paurosamente,
transitando su tutti i livelli di uno slittamento progressivo del piacere, ovvero della fruizione, dal
campo della semiotica a quello del senso comune e delle regole condivise. Del
resto, se c’è narrazione, se c’è il montaggio di eventi costruiti o immaginati
in una successione cronologica di fatti, anche con tutto ciò che di eversivo rispetto a
tale sviluppo potrebbero introdurre i flash-back, le prolessi e le analessi, gli
scombinamenti vari dell’ordine temporale, dovrà pur esserci – occorre
pensare – una “fine” che non sia una semplice e fortuita interruzione del
testo, un punto su cui il dire si concluda dicendosi esaurito, un punto, dunque, in cui
l’esaurimento fisico della pellicola coincida con la piena soddisfazione di ciò
che era necessario sapere intorno a quanto la pellicola ha trattato.
Vi è il caso, naturalmente, che
“la fine” venga a realizzare l’idea del racconto incompiuto poiché eticamente
incompletabile, istituendo il luogo superiore e lo schianto di una
“incompiutezza definitiva”... Ma in tale frangente sarà proprio la mancanza di
scioglimento ad avocare a sé il ruolo di una conclusione, finendo dunque per
esorcizzare, anche qui, ogni arbitrarietà di intervento nella chiusura del
processo testuale... E vi è non di meno il caso – come nel film giallo (e prima ancora nel romanzo
giallo, da Edgar
Poe in avanti) – in cui l’epilogo giunge ad assumersi, “in proprio”,
tutta la responsabilità morale dell’opera, ovvero l’incombenza di restituire,
nella propria esibita missione rivelatoria, l’integro e ben costruito motivo
della fiction,
proiettando a ritroso una luce di con-prensione e di conoscenza prima della
quale il racconto stesso non è stato che lenta pianificazione di un’attesa,
senso parziale e incompleto, ricerca del motivo medesimo, desiderio dello
scioglimento come teleologico culmine in cui i fili spezzati di una trama
misteriosa vengono miracolosamente a ricongiungersi in un quadro ora unitario e
sorprendentemente logico.
Nella pellicola di Michael Haneke Caché assistiamo invece al
cortocircuito disarmante di una costruzione che da un lato insegue con amorose
premure la classica sequela dei nodi del film giallo (misteri da risolvere, riemersioni inattese di un passato
che era stato rimosso, presenza ossessiva di un male incombente, allusioni reiterate a
violenze fisiche e psicologiche, metonimie di crimini perpetrati o da
perpetrarsi, clima di terrore progressivo, di angoscia mortale, fatti
sciagurati di sangue che esplodono dinnanzi agli occhi dei protagonisti e dei
fruitori dello spettacolo) e dall’altro non esita a operare un’interruzione
inattesa e inammissibile, nel corpo vivo e palpitante del racconto, là dove si
interrompe il film: lasciandola cadere in modo pressoché casuale proprio là
dove, nel percorso di uno sviluppo logico della vicenda – o, per meglio
dire, nelle attese che di tale sviluppo il film ha generato – tutto
rimane ancora insoluto e orbo di significato. Taglio arbitrario e feroce,
occorre ribadire, in un quadro temporale di vita (presunta) vissuta che
surrettiziamente il testo cinematografico ha deciso, altrettanto
arbitrariamente (va da sé), di isolare per rappresentare... Rottura che
interviene alla fine, in modo sconcertante, ma che in fondo è già intervenuta
all’inizio, dove il discorso si apre e nel far ciò inevitabilmente interrompe
“a caso” quel flusso di eventi che per definizione dichiara pre-esistente e più
ampio, e sul quale, per potersi dare, il dire narrativo ha affondato la cesoia
della propria scelta di “apertura”... Ossia, ancora, rottura che spezza alla
fine il continuum (presunto) di eventi da essa esorbitanti (per definizione) allo stesso modo in
cui l’ha spezzato all’inizio e tuttavia (per l’inizio, dico) in modo del tutto normale: sicché ci sarebbe da
interrogarsi intorno a questa strana norma, da ciascuno perfettamente accettata, per la quale
ciò che vale all’inizio – della pellicola, del racconto – non può
valere ugualmente alla fine... E gioco forza ci sarebbe da riflettere sulla
scelta di Haneke di mostrarne il paradosso assurdo o (magari, invece) del tutto
naturale.
Ed ecco per tanto la fine: la
scena conclusiva di Caché è un campo lungo a camera fissa su una scalinata di una
scuola, dalla quale si suppone (ma non è certo) debba uscire, da un momento
all’altro, Pierrot, il figlio del protagonista Georges. Dopo lunga attesa,
mentre altri ragazzi si muovono, siedono, fumano e conversano a gruppetti sulla
scala, appaiono invece i titoli di coda; e la pellicola termina senza che nulla
del “mistero” proposto dalla narrazione sia spiegato... Del resto la scena
conclusiva fa da péndant (evidentissimo) alla scena iniziale (campo lungo e camera fissa,
dalla strada, sull’ingresso della casa di Georges e della sua famiglia). Ora,
lo spettatore non può certo dimenticare mentre osserva l’una che l’altra si era
rivelata, di lí a poco, nel proseguio del racconto, come un’operazione filmica
“secondaria”, ovvero come un “film nel film”, l’opera di un ignoto autore di
registrazioni clandestine su nastri magnetici. La trama di Caché è interamente giocata sulla
presenza di tali filmati interni, incastonati nel film-cornice come altrettanti
raddoppiamenti della realtà “primaria”, narrata come tale, e il giallo verte esattamente su questi
nastri che qualcuno gira, senza farsi scorgere e per ragioni oscure, riprendendo
semplicemente certi frangenti di vita che il film-cornice propone come reali e
che tuttavia per lo piú omette di mostrare se non attraverso lo sguardo dei
protagonisti che in televisione li osservano guardando le cassette. Ma tali
frangenti, proprio perché mostrati con inquadratura dello schermo televisivo a
tutto campo, il pubblico in sala finisce per leggerli – in prima battuta
– come situati allo stesso livello di realtà del racconto-cornice, e si
accorge che si tratta di “scene registrate” solo nel momento in cui Georges
impone una pausa o un rewind per meglio decifrarli. Essi sono, d’altra parte, altrettanto reali dei fatti
reali, poiché il meccanismo narrativo ci assicura che sono stati girati dal
vero.
Cosí, giunto al mancato epilogo,
lo spettatore finisce per soccombere a un dubbio tanto “esiziale” quanto
splendidamente inutile, e persino onanistico: il sospetto che pure la scena
finale, con la scalinata di scuola, sia in realtà vista attraverso lo schermo
del televisore, grazie a un ennesimo nastro, magari da poco recapitato, che
Georges e la moglie, insieme allo spettatore, stanno guardando. Il rivolto piú
paradossale di tale legittimo sospetto discende, però, dalla constatazione
altrettanto mortifera che, se pure cosí fosse, nulla cambierebbe nella vicenda
e nel senso della pellicola... I films interni – che sono per i
protagonisti spietate violazioni del patto sociale che dovrebbe garantirli,
intrusioni nella loro vita privata da parte di una forza sconosciuta,
denudamenti inaccettabili, forse strumenti di un ricatto non ancora formulato,
prove del controllo costante che un “piccolo fratello” esercita su di loro,
veri e propri intollerabili stupri telematici o cinematografici – sono invece per lo
spettatore poco piú che elementi di compensazione narrativa, alla stregua di flash-back esplicativi. Perché, se rivestono
nella logica del narratum il ruolo di oggetti interni (sia pure filmici), ossia
precisamente di “corpi di un reato” (spionaggio, effrazione della sfera
privata, ecc.), hanno invece il compito nella logica della narrazione di offrire informazioni
altrimenti negate.
L’esempio piú pregnante è relativo
al nastro che mostra il seguito della vicenda del primo incontro di Georges con
Majid... Ma procediamo con ordine. Georges è stato condotto, da una cassetta in
cui esso appare, a cercare un luogo che scopre come effettivamente esistente
nella periferia della città in cui vive (Parigi) e a identificarlo come
l’attuale abitazione di un suo vecchio compagno di infanzia, il bimbo Majid,
rimasto orfano durante la guerra di liberazione algerina, che i genitori di
Georges avevano adottato ma che Georges, bimbetto viziato e crudele, era
riuscito a far allontanare con false accuse. I suoi antichi sensi di colpa e il
legame che appare oggettivo tra le cassette e l’algerino (ora quarantenne) lo spingono a
persuadersi che sia quest’ultimo l’autore del ricatto e dei films. Georges ne è
convinto al punto da minacciare pesantemente Majid dopo aver fatto irruzione a
casa sua, ma lo spettatore da subito tende a pensare che Georges si sbagli:
vuoi perché il giallo si rivelerebbe in tal caso troppo semplice e banale (motivi esterni,
psicologia della narrazione), vuoi perché Majid appare “sinceramente stupefatto”
della visita di Georges (motivi interni, piano del narratum). La sensazione dello spettatore,
spettatore del film di Haneke intendo, è di lí a poco confermata dalla
fruizione di una nuova cassetta immediatamente successiva alla visita, la quale
mostra lo stupore, l’amarezza e la totale sincerità di Majid lacrimante e disperato
anche dopo che Georges se ne è andato. Qui, appunto, un dato altrimenti
inconoscibile viene fornito allo spettatore tramite la fruizione della
cassetta. Ma il medesimo dato, guarda caso, serve a Georges, che è piú di tutti
fruitore del nastro magnetico, a rafforzare la propria convinzione circa la
colpevolezza dell’algerino. Solo lui, secondo Georges, può aver girato la
scena... e pertanto quel pianto cosí autentico sarà non di meno finzione a puro beneficio di Georges:
Majid si dispera benché non sia piú in presenza di alcuno da persuadere, ma in
realtà potrebbe farlo recitando una parte e sapendo benissimo che questo
qualcuno poi lo vedrà piangere in cassetta...
Indecidibilità totale. A questo
punto appare chiaro che nulla può essere chiaro né mai potrà chiarirsi. Tutte
le distinzioni e le barriere tra verità e menzogna saltano, la finzione prende
il sopravvento sul film: ossia quel sopravvento che essa ha da sempre, in
qualsiasi film (di fiction, appunto); ma le vittime di tale statuto fittivo e falso
divengono gli stessi protagonisti del film, i personaggi che –
all’interno della propria condizione di elementi della finzione –
dovrebbero rimanere immuni dal dubbio che il patto narrativo a cui soggiacciono
sia solo un fenomeno linguistico, e che la finzione che li avvolge sia appunto
solo una finzione. La quarta parete crolla, il patto narrativo si spezza. Ogni scena del film,
anche quelle dichiarate reali, potrebbe essere frammento di una cassetta da
qualcuno clandestinamente girata per ricattare Georges, il quale sarebbe
ricattato e terrorizzato, in tal caso, solo in immagine su nastro... Questi a
un certo momento ha un incubo: si rivede nella vecchia casa della propria
infanzia insieme al piccolo algerino, e nell’incubo trasfigura avvenimenti
(presunti) reali, ossia (realmente) accaduti (solo) in base al racconto che
Georges ne fa alla moglie e che per noi spettatori è tecnicamente un flash-back. Ma la moglie, e noi con lei, non
potrà mai sapere se ciò che Georges racconta è veramente accaduto, e noi
– che assistiamo alla narrazione dell’incubo, tecnicamente un altro flash-back – non potremo mai sapere se
le cose siano magari andate come nell’incubo invece che come nel racconto. Ma le
cose sono
realmente andate in qualche modo? E dove? No, con ogni evidenza, non sono andate, o meglio: sono
andate da nessuna parte. Poiché esse vanno e non vanno esclusivamente in una finzione piú ampia e perciò
ancor meno attendibile, il film di Haneke. Esso ci induce a supporre una realtà
di accadimenti che già di per sé è mendace, e pretende di indurci poi a cercare
di stabilire che cosa è conforme a tale mendacia-quadro e che cosa in essa è
falso, ossia due volte falso, ossia (forse, pertanto) vero.
Un film geniale, che si disfa
mentre si fa. Metalinguistico senza esserlo in modo dichiarato, un anti-film nell’accezione piú raffinata del
termine. Anche la scena clou, la più drammatica, quella in cui vediamo Majid togliersi
la vita per mezzo di un gesto atroce e improbabile, il lampo inatteso di una
coltellata autoinferta che gli squarcia la carotide e la giugulare, in cui
vediamo il suo sangue sprizzare ovunque, è recitazione e teatralità pura: con
un pretesto egli ha chiamato Georges ad assistervi e, un attimo prima di agire,
gli ha detto: «desideravo che tu vedessi questo». La moglie, Anne, dubiterà del
racconto del marito: a giusto titolo. Pura visione, spettacolo, puro
racconto... Un film che infatti produce su chi lo guarda l’effetto ambiguo
dell’attrazione in un coinvolgimento accecante (la seduzione magica della regia
di Haneke, capace di allestire un apparato tecnico-retorico di formidabile
potere persuasivo) e simultaneamente della continua “messa in distanza”, del
rigetto verso l’esterno, come per l’obbligo morale di far sentire allo
spettatore l’incongruità del suo stesso lasciarsi catturare, come per
sottolineare la menzogna dell’emozione estetica in generale.
Nella scena del suicidio, come del
resto ovunque nella pellicola, si finisce per percepire la presenza sinistra e
misteriosa di qualcosa o qualcuno che sta tra lo spettatore e la realtà
rappresentata; in certo qual senso è come se prendesse anima e spessore la
presenza stessa della rappresentazione; come se vi fosse un “regista” delle
cassette registrate che non è affatto là dove Georges e Anne lo cercano (pur se
in tale ricerca consiste il giallo, chi è?), che non è presso Majid o presso suo figlio, il
quale vive forse l’ansia di vendicare il padre dal torto subíto ab origine; che non è in realtà nel film, ma piuttosto fuori di esso, in
un altrove che non è però nemmeno la realtà nostra, di noi che il film e i
nastri guardiamo confondendoli tra loro; è come se vi fosse qualcuno che ha
registrato tutto: le cassette e i fatti che esse (ri)producono, Georges, Anne,
Majid, i figli, i bimbi nella vecchia casa di campagna, i ricordi e le colpe;
qualcuno che può tutto, anche collocare una videocamera in casa di Majid senza essere Majid
o suo figlio, un regista-demiurgo la cui azione si impone e che tuttavia non è neppure
Michael Haneke... Semmai un suo alter-ego, un pre-autore, qualcosa di simile a
ciò che per don Chisciotte e per Cervantes fu il mitico Cide Hamete Benengeli,
una cornice ulteriore rispetto alla cornice-film, un autore più interno e più
arcano dell’autore Haneke, un regista immaginato dall’autore come autore
dell’intrigo e della sua inestricabilità: qualcosa, anche qui, di assolutamente indecidibile...
e intorno alla cui inesplicabilità tutto si piega.
|
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -