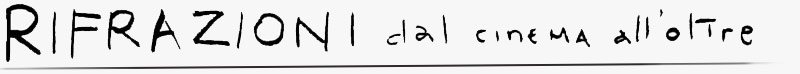
CIVILTÀ
ALIENA
Elementi
di educazione civica in District 9 (2009, di Neil Blomkamp)
di MASSIMO SCALVINI
Un'idea, un
concetto, un'idea
Giorgio
Gaber, Un’idea La fantascienza svolge una
funzione di Educazione civica che nessun altro genere – letterario o
cinematografico - esercita in modo così chiaro, lineare, profondo e radicale.
Almeno in due direzioni sviluppa questa sua funzione: in un verso abbiamo la
cosiddetta fantascienza distopica che ci ammonisce costantemente nei confronti
di una non troppo ipotetica perdita della libertà – in tutte le sue molte
forme – e che lancia la sua feroce critica verso tutti i totalitarismi,
di qualsiasi matrice, passati, presenti e futuri. Poi c’è tutto il mondo degli
alieni.
In un breve racconto
per ragazzi di Edward Dentinger Hoch intitolato Zoo, un affarista
interplanetario, il professor Hugo, atterra ogni anno sulla terra per esibire
le sue bizzarre creature da altri mondi chiuse in gabbie come pericolosi
animali; per vederle gli esseri umani attendono in coda a lungo e pagano un
biglietto. Una volta tornati sul loro pianeta i “mostri” alieni raccontano ai
loro familiari di come sia stato interessante ed affascinante il viaggio
compiuto e quanto valesse la pena pagare il biglietto per quel viaggio. La
visita la più interessante? Quella sulla terra con i suoi singolari esseri
umani: riparati da sbarre per proteggersi da quei pericolosi animali che
portano indumenti sulla pelle e camminano su due zampe.
Un ribaltamento di ruoli semplice
e geniale. Chi sono gli alieni? Chi sono gli altri?
District 9 racconta
la stessa storia. In modo singolare, affascinante, estremo, definitivo, con una
regia abbagliante che porta a compimento alcuni decenni di sperimentazioni e
contaminazioni tra generi e tecniche cinematografiche, racconta la stessa
storia.
Sudafrica, si potrebbe pensare che
l’intero immaginario contemporaneo possa aver trovato in quella nazione, in cui
le differenze razziali per decenni furono legge, il suo paradigma: la figura
mastodontica di Mandela con il suo grande ideale e le tensioni ancora irrisolte
raccontano molto anche della nostra realtà più recente, ma anche delle timide
aperture, delle diffidenze, delle ostilità verso chi è altro da noi, del
desiderio di allontanare ciò che c’è alieno. Lo stesso regista afferma che:
«L’idea di base [del film, ndr] è generata decisamente dall’idea di due
razze che si incontrano sulla soglia di una delle due. Voglio dire, questo è
quello che è il Sudafrica. Non c’è assolutamente alcun dubbio che sia così».
[1]
L’intento era chiaro fin dalla
virale campagna di promozione del film. La produzione aveva tempestato varie
città con cartelli pubblicitari che riprendevano la grafica di normali cartelli
di divieto ma i messaggi d’inquietanti avvisi razzisti che rimandano a tempi
meno nobili ma non del tutto scongiurati. Non solo, questi cartelli invitavano
anche a segnalare casi “sospetti” sul sito del film.
A Johannesburg, nei primi anni ’80,
sono atterrati gli alieni: malati e denutriti. Da allora sono stati ammassati
in una baraccopoli alle porte della città creata per loro; ogni tanto qualche extraterrestre
scappa tra gli umani alimentando l’astio e l’intolleranza. Queste le premesse
su cui si sviluppa District 9.
Gli umani intervistati dalla TV
gridano che bisogna toglierli di mezzo perché si spendono troppi soldi per
tenerli lì; per tutti sono degli incivili, delle bestie, dei gamberoni. Devono essere allontanati
dalla vista. Per questo, con un atto di finta legalità e umanità, viene
destinata loro una nuova area in cui essere rinchiusi: più salubre forse, più
lontana dalla città e dalla vista dei cittadini sicuramente. Lo scopo vero
dell’operazione è quello di cercare e capire il funzionamento delle armi di cui
sono in possesso gli alieni.
Singolare ed istruttiva la vicenda
dei nigeriani che vivono all’interno del District 9: continuano ad accumulare
armi che non sono in grado di utilizzare, immagazzinano beni inutili e lo fanno
con una ferocia inaudita. Un capitale inutilizzabile accumulato solo con la
prospettiva futura di poter dominare su ciò che gli sta attorno: un mondo arido
in cui gli unici che dimostrano un minimo di sentimenti sono degli esseri che
si nutrono di cibo per gatti e che non vedono l’ora di lasciare il nostro
pianeta.
Molti hanno sottolineato come la
forza del film sia quella di riuscire a mescolare in modo ardito e sapiente
molte tecniche di ripresa non convenzionali: il film inizia come un mockumentary per poi innescare riprese
cinematografiche tradizionali, riprese con macchine a mano, interviste a
parenti ed esperti, riprese con videocamere a circuito chiuso, riprese a mano.
La sapienza dell’ibridazione delle tecniche di ripresa nasconde una forte
critica ai media che istigano l’intolleranza attraverso la diffusione delle
sole idee favorevoli all’opinione dominante.
L’ibridazione tecnica rimanda a
quella biologica che avviene tra l’umano Wikus van de Merwe e gli alieni quando
entra in contatto con il fluido biologico che permette di mettere in moto l’astronave e di far funzionare le
micidiali armi aliene. La contaminazione costringe il capo dell’operazione MNU
a perdere la propria identità, a diventare un ibrido bastardo – viene
accusato, a torto, di aver avuto rapporti sessuali con gli alieni – un
reietto ancor peggiore degli stessi gamberoni;
a perdere le proprie sembianze, il proprio corpo.
Wikus van de Merwe diventa
prezioso, ricercato, perché è l’unico umano in grado di far funzionare le armi
degli alieni che utilizzano una tecnologia ancora sconosciuta ai terrestri.
Viene ricercato, braccato e lui si vede costretto a confrontarsi con quegli
esseri che fino a poco prima aveva mal sopportato. Ne diventa complice, ne
capisce i sentimenti: soprattutto ci mostra l’umanità dell’altro e la vergogna
della nostra intolleranza. I primi sintomi evidenti della sua trasformazione si
manifestano durante la festa per la sua promozione a capo dell’operazione, il
suo nuovo corpo nascente rifiuta la sua vecchia vita e lo costringe a vomitare
sulla torta. Durante la metamorfosi diventa più “umano”, meno denigratorio.
Soprattutto diventa più forte.
Diventa prezioso nel momento in
cui si contamina, in cui la vicinanza con l’altro è massima. Fa paura non perché è diventato un figlio di puttana mezzosangue – come al solito si tenta di
esorcizzare la paura della diversità con l’offesa e lo spregio – ma
perché lui è una nuova forma di
umanità fino ad allora sconosciuta. Un uomo nuovo che non ha semplicemente
fatta sua l’idea della diversità, ma
ne ha fatto – suo malgrado – il proprio corpo. Se l’è letteralmente
mangiata quell’idea. Diventa il diverso che trova casa tra i diversi. Anche
se inizialmente rifiuta il cambiamento – si taglia il braccio mutato
– troverà affinità sempre maggiori con i gamberoni – il piccolo alieno gli dice che sono uguali
– e in particolar modo trova un destino comune: vogliono entrambi tornare
a casa. Nasce un’alleanza tra umano e alieno che ci racconta come si potrebbe
avere un futuro collettivo, magari un avvenire in cui ognuno ritrova la propria
casa. Ma l’arroganza, la superbia e l’avidità dell’uomo – come genere,
meno come specie – porta al fallimento. Costringe l’essere nuovo a vivere
e a rovistare nella spazzatura per costruire quei fiori fatti di rifiuti, come
lui rigettato tra i reietti, da mandare all’amore che ancora lo aspetta. Ultimo
atto poetico di un’opera che prima di tutto vuole educare alla convivenza, al senso
civico necessario per costruire un mondo per tutti e non solo per qualcuno.
Un mondo che ancora non sa guardare all’unicità, ma continua a perdersi nella
paura, nella sicurezza dell’uguale, a costruire barriere e gabbie e, in questo
modo, si perde la bellezza di quei fiori fatti di spazzatura.
[1] La problematica aliena. Il diario di un produttore. Capitolo 1: Immaginare District 9. Nei contenuti speciali del DVD edito da Sony Picture Home Entertainment (2010). |
 |
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -
