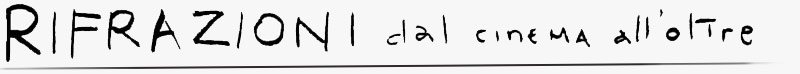
|
DOSSIER CINETEATRO
Intro
LA SCENA DEL
CINEMA
Silvia Mei
Questa
premessa non è illustrativa tantomeno introduttiva al materiale raccolto, fortemente orientato e selezionato nei suoi soggetti e nel
taglio storico-analitico. È comunque doverosa una nota, anzi due, interrelate.
La prima
è la programmatica e statutaria evasione di esaustività,
o meglio ricerca di parzialità. Non sarebbe stato possibile, tantomeno utile,
essere completi su un’area che per la superfetazione saggistica, libresca,
congressuale prodotta nel tempo è diventata più che una materia, senza tuttavia
raccogliere durevoli e convincenti acquisizioni storico-critiche. Una relazione
come quella tra cinema e teatro – molto meno di
una tenzone, molto più di un baratto (di soggetti, di attori, di realtà
materiali come set, costumi, pratiche, e poi di quelle scrittorie, attoriche,
drammaturgiche, scenografiche) – è stata una vera e propria amicizia di cui occorrerebbe scrivere
seriamente la storia.
Tuttavia,
la dichiarata incompletezza che qui si offre non vuole suonare da giustificazione per eventuali assenti, diversi e non meno
importanti dei presenti. E qui si arriva alla seconda premessa. Il criterio
selettivo è di investimento “autoriale”, se vogliamo,
rivendicando nella regia come scrittura (Astruc) e come principio regolatore
della messinscena (Craig) il discrimine e il parametro valutativo delle
esperienze e prassi individuate. Registi come autori (nel doppio specifico,
teatrale e cinematografico), quale garanzia di una convergenza, prossimità o
anche discrasia stilistica nell’intervallo tra pratiche di scena e di set. Andando in ordine, di chi sentiamo nostalgia in questo dossier: Grigorij Kozincev, Laurence Olivier, Andrzej
Wajda, Luchino Visconti, Rainer Werner Fassbinder, Peter Stein, Richard
Foreman, Sam Mendes, Fausto Paravidino (quest’ultimo pur non essendosi ancora
espresso in lunghezze apprezzabili e stimabili cinematograficamente).
Per concludere (o forse per includere).
Non voglio arrischiare una critica, lo spazio che vi dedicherei non la giustificherebbe, tuttavia l’apprezzamento di quella che vorrei ribadire
essere, tuttora, un’amicizia, e non una divergenza o un conflitto
(epistemologico e prima di tutto ontologico), tra teatro e cinema merita un
trattamento critico e teorico diversamente sensibile o sensibilmente diverso.
Basta affacciarsi o solo transitare sulla scena teatrale contemporanea, queste
nostrane iperscene di nuovo millennio, per capacitarsi dei pregiudizi che ancora separano la
mediazione tecnologica dalla comunicazione dello spettacolo dal vivo nella valutazione
schermo-scena. In diverse occasioni ho affrontato la
nozione di “teatro iconografico”, legata a quella di reperto scenico, ma usata anche in senso lato come “teatro della
visione”, in riferimento alla ricerca dei nuovi linguaggi della scena italiana.
La forte impronta iconografica che ritroviamo in gruppi come Anagoor, il setting fotografico di Città di Ebla o lo storyboard
visivo di gruppo nanou, e ancora i prestiti formali dal cinema in Muta Imago,
secondo una lezione di cifra Lepage, dovrebbe promuovere una rimessa a punto
dello sguardo, perché di questo alla
fine si tratta. E senza tuttavia dar troppa enfasi a questa constatazione, credo che proprio il teatro contemporaneo italiano, in
quelle forme che hanno portato a definire o riconoscere una deriva della
rappresentazione, in realtà non hanno che rafforzato illusivamente e
visivamente quella nozione, mettendo piuttosto in crisi il dispositivo teatrale
in se stesso, il teatro tout court.
Non per riproporre una contestatissima equazione di memoria
ragghiantiana, teatro=cinematografo,
ma forse dobbiamo ripartire da qui e fare i conti con una controversa e
permanente testualità, quella dell’immagine.
DALL’OGGETTO-ANIMA
ALLA CARNE-DERMA
ATTRAVERSAMENTI
NELLA SCRITTURA PER IL CINEMA DI ANTONIN ARTAUD
Lucia Amara
C’è la ricerca di una visione o, meglio,
di una vista sullo/dello spirito
nelle scritture per il cinema di Antonin Artaud. E questa indagine coincide, e
si svolge contemporanea, alla ricerca di un affondamento delle forme, un
travaglio a cui Artaud, fin dagli esordi della sua
opera, sottopone il linguaggio, quello della poesia, della grammatica e del
teatro, della scrittura e della voce. A questa triturazione o rimescolamento delle cose e
dello spirito – come dice Artaud in una delle prime note sul cinema – non si sottrae neanche il
linguaggio cinematografico che, come tale, è ancora a venire:
Pretendo dunque film fantasmagorici, film poetici, nel
senso denso, filosofico della parola, film psichici. […]
Film in cui sia operata una triturazione, un rimescolamento delle cose del
cuore e dello spirito al fine di conferirgli la virtù cinematografica che deve essere ancora cercata
[1]
.
Anima, reale, linguaggio e forma sgorgano in Artaud dalla
medesima fonte speculativa e sono i temi più pregnanti della produzione coeva
alle prime scritture per il cinema che si collocano tra il 1924 e il 1925. Questa produzione non è, dunque, isolabile da quella linea genealogico-speculativa che va dalla Corrispondenza con Jacques Rivière a Il Pesa-Nervi
[2]
.
Si tratta di scritti in cui Artaud si sta interrogando sul linguaggio e sulla
forma in rapporto ad anima e spirito, elementi inscindibili dalla materia degli
oggetti e del pensiero, l’un piano emanazione dell’altro. «Mi manca una concordanza
delle parole con la minuzia dei miei stati», scrive Artaud
[3]
. É in questa faglia tra linguaggio e forma che Artaud colloca l’immagine e le
potenzialità che questa, come specimen del cinema, può sviluppare.
1. In una delle lettere a Rivière, Artaud denuncia il suo
mancamento di pensiero come una malattia che definisce «affondamento centrale dell’anima» (effondrement
central de l’âme
[4]
) e che provoca una
inadeguatezza (o sproporzione) tra forma e spirito. Una sorta di fragile presa sul reale che Artaud considera come «inapplicazione all’oggetto» (impuissance à me concentrer sur un objet), una debolezza che è
diretta emanazione dell’anima, della sua anima.
Il dispositivo del sogno – caposaldo della poetica
surrealista – costituisce un elemento fondante per interpretare e
restituire il reale, oltre che un luogo da cui ricavare nuove
leggi dello spirito, ma sempre tenendo fermo un controllo affilato sulla
realtà, un occhio intellettuale nel delirio delle forme:
Non rinuncio
a nulla di ciò che è Spirito. Voglio soltanto spostare il mio spirito altrove
con le sue leggi e i suoi organi. Non mi abbandono all’automatismo sessuale
dello spirito, ma al contrario in questo automatismo io cerco di isolare le
scoperte che la ragione chiara non mi dà. Io mi abbandono alla febbre dei
sogni, ma è per ricavarne delle nuove leggi. Io ricerco la moltiplicazione, la
finezza, l’occhio intellettuale nel delirio, non la vaticinazione
azzardata
[5]
.
[…]
PASSAGGI A
DONDOLO
PALINDROMIE
BECKETTIANE
Vito M. Bonito
Passi. Dondola.
Passi. Respirazione impercettibile. La sedia a dondolo assorbe il balbettio
motorio di un corpo in abbandono, qui, ora, dove bisogna stare, sostare: una pausa di vita, una cadenza. Cosmica e comica, semplice annominatio.
La
dondola, cinque minuti, vale tutto l'Antipurgatorio, la quiete embrionale di
Belacqua. La «Belacqua fantasy» di Murphy prende vita e si allarga nella lullaby, ovvero Rockaby, della Berceuse.
La sedia-ninnananna culla lo spirito di Murphy, una «sfera cava», una monade
adagiata, imbozzolata nella propria "negghienza" accidiosa.
Murphy,
come Belacqua, attende e ripete, nel come and go di un corpo-dondolo conficcato in un Purgatorio in progress, sferico-joyciano,
non dantescamente unidirezionale, bensì «adirezionale, o multidirezionale»,
dove «un passo avanti equivale per definizione a un passo indietro» (Dante...
Bruno. Vico... Joyce). Allora non fa differenza muoversi o non muoversi,
avanzare o indietreggiare. Muoversi è non muoversi, avanzare è indietreggiare:
una reversibilità senza rotta, come quella della berceuse,
da Murphy a Film a Rockaby.
*
Lingua
III. Un ritornello. Un'immagine-ritornello, secondo Deleuze. Immagini lievi,
lucore della permutazione, come in una delle Mirlitonnades:
écoute-les / s'ajouter / les mots / aux mots / sans mots /
les pas / aux pas / un à / un (ascoltali / congiungersi / le parole / alle
parole / senza una parola / i passi / ai passi / uno a / uno)
Questo andirivieni di passi e parole,
come il moto perpetuo di Footfalls (Passi) e la ninnananna della berceuse – da Murphy a Film a Rockaby (Dondola)
– sono il primum dell'immagine che si dà nella propria azione
riflessiva, nel ritornello di una lingua che non conosce e non rivela un senso,
il senso. Lingua-passi che parla, passa e ripassa ogni forma e possibilità di vita, progetta una prossemica del vuoto e del fallimento,
un’arte della respirazione craniale che raschia ritmo e stile, comprime l'umano
all'osso, allo scheletro di legno di una sedia: «legno chiaro lucidissimo,
luccicante nell'oscillazione. Poggiapiedi. Schienale verticale. Braccioli curvi
all'indentro, per suggerire l'idea di abbraccio» (Rockaby). Una sedia con due fori come occhi fissi lontani e torvi, stesso
sguardo di divinità sumera appesa al muro (Film).
[…]
HERMITAGE E NOSTRA
SIGNORA DEI TURCHI DI CARMELO BENE:
IL CORPO
DEVASTATO
Jean-Paul
Manganaro
Pochi
anni separano gli inizi teatrali di CB, nel 1958, da quelli dell’esperienza
cinematografica. Nel 1967 gira Hermitage,
seguito nel 1968 da Nostra Signora dei
Turchi. È possibile accostare i due film che esprimono quello che può
succedere a e attraverso la creazione, e che sono serviti a costituire
supporti, note e citazioni uniche nei processi creativi dell’epoca, tanto
italiana quanto internazionale. In effetti, la struttura figurale dell’opera di
Bene è tale che ogni confronto col solo italiano che, nella stessa epoca,
avesse voluto dire qualcosa di più degli altri, vale a dire Pasolini, sembra
impossibile, essendo l’opera di quest’ultimo, a
tratti, troppo legata e limitata a uno storicismo critico tormentato dalle
passioni del senso e della significazione etica e politica. Tantomeno possiamo
compararla con l’oceano dell’underground internazionale, e in particolare newyorkese, che vede
manifestarsi, nel corso di quegli anni, una molteplicità di pseudo-militantismi
sfocianti nel tentativo di annientare le reificazioni. Pensiamo ai risultati
raggiunti da un Andy Warhol, o anche da un Paul Morissey, che mettono in mostra la gente e il chiacchiericcio, concedendo
ampi spazi alle nuove formulazioni «dello stare insieme».
È
probabilmente la struttura dell’estremismo teatralizzato a permettere a Bene di fuggire dai fenomeni che ci relegano nei
sistemi di comunicazione e di trasmissione: troviamo in lui una cultura
teatrale elaborata non come rimozione analitica, e neanche come rivisitazione
post-modernista, ma come la sola possibilità di creazione, esprimentesi nelle
sue affermazioni tutte in negativo: non si fa teatro col teatro, non si fa
cinema col cinema. Per arrivare all’espressione di un autobiografismo
sconcertante: non si fa vita con la vita. Questa
cultura della teatralizzazione spicca in Hermitage, o in Nostra Signora dei Turchi,
con una postura immediatamente determinata dal corpo dell’attore, il corpo attoriale, che investe allo stesso tempo il corpo
dell’opera, l’antico corpus. Bene è
solo nel lavoro sull’opera corporale: Hermitage, Nostra Signora dei Turchi, ma anche Don Giovanni, presentano delle situazioni in cui il corpo è posto
direttamente di fronte alla propria materia, una materia falsamente estasiata o
esaltata, già in contrasto con tutti i sistemi di mercato che ruotano attorno
all’immagine e che la elaborano come realtà e verità di un’«unità» imprecisa.
Si
tratta di film che, sotto l’apparenza dell’intimismo
più inquietante – ciò che Bene chiama «il privato» – negano tutti
gli stati e tutte le stratificazioni dell’interiorità affettiva e mentale del
corpo; che lo sventrano con una crudeltà senza precedenti, anche se essa ha
potuto un tempo essere supposta e teorizzata all’interno di relazioni
violentemente biografiche, quale è stata l’esperienza di Artaud o già quella di
Lautréamont. Un intimismo che mette in scena la passione come meccanismo motore
delle volontà possibili e immaginarie del corpo; un’effettuazione e una
diseffettuazione che sembrano essere l’epicentro di tutta la meccanica della sua opera, dal romanzo al cinema, passando per il
teatro. In Hermitage, come in Nostra Signora dei Turchi, l’accento è
posto, parallelamente al corpo, su quello che possiamo chiamare il romanzo della cosa, sul derivato che costituiscono le
lettere; lettere e romanzo che sono materialmente, a partire dal XIX secolo, da
Goethe fino a Thomas Mann, il corpo necessitante e bisognoso della creazione.
[…]
|
[1]
Antonin Artaud, inchiesta lanciata da
René Clair sul n. 15 di “Le Théâtre et Comoedia illustré” (marzo 1923), ora in Del meraviglioso. Scritti di cinema
e sul cinema, a cura di Goffredo Fofi, Minimum fax, Roma 2001, p. 11.
[2]
Entrambe le opere sono pubblicate in trad. it. in Id., Al paese
dei Tarahumara e altri scritti, Adelphi, Milano 1966.
[3]
Id., Il Pesa-Nervi, cit., p. 42.
[4]
L’espressione,come anche quella
di seguito, è dalla scrivente tradotta dal testo originale.
[5]
Id., Manifeste en langage clair, in Œuvres, a cura di Évelyne Grossman,
Quarto-Gallimard, Parigi 2004, p. 149 (la traduzione e il corsivo sono della
scrivente).
|
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -



