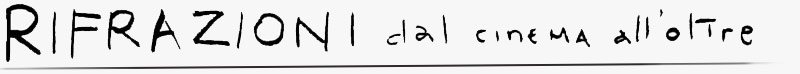
DOSSIER ADAPTATIONS
DAL LIBRO AL FILM
INTRO DOSSIER ADAPTATIONS
Jonny Costantino
|
Mi
sembra che il cinema abbia sbarazzato la
letteratura da diversi assurdi
pensieri, del tipo:
movimenti, rapidità, inseguimenti,
colpi di scena,
come la fotografia aveva finalmente
guarito la
pittura dalla preoccupazione della
“somiglianza”.
Le
arti si aiutano meno per ciò che si prestano
vicendevolmente che per
ciò che si tolgono.
Jean Paulhan,
1925
Sebbene parlino la stessa lingua,
letteratura e cinema sono arti scritte in linguaggi sì
compatibili ma differenti. È inevitabile che nel passaggio dall’una all’altro
(come viceversa, in linea ipotetica) le rispettive peculiarità (linguistiche,
espressive) vadano perdute. Un romanzo è irriducibile.
Come ridurre per lo schermo i tic, le ripetizioni, l’esagerazione, la
musicalità delle frasi radicali di Thomas Bernhard o
le viscerali infilate di detonazioni metaforiche di Henry Miller o il lirismo
midollare nebulizzato tra i puntini sospensivi di Louis Ferdinand Céline? Come rendere le elefantiache derive filosofiche di Herman Melville o gli incistamenti poetici della prosa
concettosa di Georges Bataille? Tutto si può fare,
certo, ma si fa cilecca se la preoccupazione del regista è semplicemente quella
di impacchettare un libro in forma di film, e non creare qualcosa di nuovo,
attraverso una materia prima testuale profondamente interiorizzata o
spietatamente usata. Per questo il fan del romanzo
– che va al cinema col bagaglio di fantasie e visioni scaturite dalla
frizione tra la propria immaginazione e la pagina scritta – di regola
resta deluso, se pensa di vedere in movimento il suo romanzo. Nel trapasso cinematografico, certe proprietà
letterarie non possono che svaporare. Devono nebulizzarsi, e ricadere in altra
forma, per rifrangersi attraverso lo sguardo di un diverso autore, un autore di
cinema. Se è vero allora quanto afferma Jean Paulhan in epigrafe (sull’alleggerimento che il cinema
avrebbe consentito alla letteratura), è altrettanto vero che la letteratura
sgraverebbe a priori il cinema da tutta una serie di perifrasi (sintattiche,
narrative) tipiche della pagina scritta ma superflue ai fini del colpo d’occhio e d’orecchio proprio
della sintesi audiovisiva. Detta altrimenti: è zavorra il giro di parole che,
applicato al cinema, non si trasforma in un giro
d’immagini e suoni in grado di intensificare lo sguardo su una situazione,
un’azione, una pura visione, sotto il riflettore di una determinata poetica e
dello stile di regia da essa forgiatosi.
[…]
FOLLOW THE YELLOW BRICKROAD!
Chiara Lagani
The Wonderful Wizard of Oz (Il meraviglioso mago di Oz, 1900) di
Frank Lyman Baum
The Wizard of Oz (Il mago di Oz,
1939) di Victor Fleming
Wild at Heart (Cuore Selvaggio, 1990) di David Lynch
Per più di tre anni
[1]
ho
lavorato con la mia compagnia, Fanny & Alexander, a partire dalla storia
del Mago di Oz, muovendomi in maniera assai
trasversale (spiraliforme?) tra alcune opere importanti: tra tutte un libro
famoso (Il meraviglioso mago di Oz), scritto nel 1900 da Frank Lyman Baum, un film famoso (Il mago di Oz) del 1939, diretto da
Victor Fleming, e un secondo film, diversamente famoso e più recente, di un
regista che da sempre per noi è un grande riferimento, David Lynch: Cuore Selvaggio (1990). Sono tre opere
complesse, che dispiegano orizzonti molto vasti, e che per anni si sono
annodate alle nostre, provocando questioni, scatenando cicloni capaci di
sollevare una casa e scaraventarla in mondi stranieri in cui il meraviglioso
non si distingue facilmente dal quotidiano, e la realtà delle cose, come la
realtà del sogno, ha sempre un cuore incomprensibile. Questo uragano composito, fatto di opere che interagivano come leve impressionanti su
un desiderio originario che potrei forse chiamare ispirazione, ha prodotto una
grande possibilità: la riattivazione dell’immagine mitica di partenza, la sua
conservazione e rimessa in vita attraverso la pratica più fertile che io abbia
mai conosciuto: “l’inquinamento”. Mi piacerebbe partire da questa parola, che è parola solitamente negativa e convertirla in positivo in
questo scritto per “Rifrazioni”: credo infatti sia importante riabilitare
questa parola per introdurla in un numero dedicato alle derivazioni, alle
traduzioni, alle rinascite di immagini da immagini, di storie da storie, opere
da opere. Vorrei usare la parola inquinamento come attributo speciale di questi percorsi (e in genere di quelli dell’arte), vis vitalis,
di contro all’ideale di purezza (e inalterabilità) delle fonti. Contro
l’ideologia della purezza questo tipo di traduzione, di derivazione, pratica la
poetica del pericolo. In arte, credo, il contrario di “purezza” non è mai
l’impuro ma il “pericolo”. La questione della relazione col modello dovrebbe
essere allora non tanto una questione di recupero o di derivazione della sua immagine mitica, ma una questione di sopravvivenza, di incarnazione. Incarnazione in una sola, varia, Dorothy in viaggio, ad
esempio: Dorothy Gale, Dorothy/Judy Garland, Dorothy/Lula. Viaggiando attraverso più tracciati nel
tentativo di disegnare il proprio, si inaugura una
nuova figura, che alla fine ha sempre lo stesso andamento: la spirale, il
vortice. Di questo strano viaggio attraverso un
labirinto che io, nei panni di Dorothy, mi sono trovata a percorrere e
ripercorrere, vorrei limitarmi semplicemente a enumerare sette possibili
curvature, sette domande, sette falsi o veri passaggi. Al lettore il compito di
dare senso a ogni passo del suo personale viaggio,
colmare i vuoti, rifrequentare le opere, sopportare
la profondità dell’abisso della storia che le ha generate, come fa Dorothy nel
film quando si sporge dalla finestrella, al centro dell’occhio immobile del suo
ciclone. Per conto mio, infatti, non ho mai tracciato
una vera mappa del viaggio, non ho una direzione corretta da indicare a chi
volesse incamminarsi per questa via. Dove si arriva? Come si arriva? «Just follow the Yellow Brickroad»,
gridano i Munchkins alla bambina: è una parola!
Questo sentiero inizia e non finisce, sembra tornare indietro di continuo, si
avvolge su se stesso, demarca un territorio, un luogo vago e indefinibile! In
questo luogo ho a lungo sostato, ma a volte ho il dubbio di averlo davvero
toccato; altre volte ho il dubbio di non riuscire a tornare indietro. È un
luogo pieno di porte quello, non sempre fatte per entrare e per uscire.
[…]
IL POTERE DELLE FORME
NOTE SU RITRATTO DI SIGNORA DI HENRY JAMES E JANE CAMPION
Mario Pezzella
The Portrait of a Lady (Ritratto di signora, 1881) di Henry James
The Portrait of a Lady (Ritratto di signora, 1996) di Jane Campion
Letteratura
e immagine. Nella Prefazione scritta
nel 1906 per il suo
romanzo la Coppa d’oro, James si chiede quale rapporto
possa esistere tra la scrittura letteraria e un linguaggio visivo che ad essa
si riferisca: si tratta in questo caso della fotografia, anche se è lecito pensare
che James non ignorasse gli inizi del cinema muto
[2]
.
Innanzitutto egli esprime il suo scetticismo sulla possibilità di una
traduzione reciproca delle due forme di espressione;
c’è anzi il rischio che l’«illustrazione» spinga il lettore a dimenticare il
«brulicare di immagini immediate» proprio del romanzo. Queste «qualità
pittoriche» dell’opera letteraria non possono essere trasposte in un altro
medium linguistico, senza tradirne il significato. Sarebbe insomma –dice
James – come «servire carne e pesce nello stesso
piatto».
Tuttavia esiste un’altra
possibilità: invece di mirare a una mimesi illustrativa della scrittura
originaria o di minimizzare la differenza tra i due linguaggi, si può esplicitare e sottolineare la loro differenza e fare di essa
una virtù. La fotografia può mantenere un rapporto creativo col romanzo, purché
affermi senza reticenze di essere altra cosa da esso: non una sua trasposizione più o meno fedele, ma una connessione nuova e
originale di alcuni elementi del libro. Non si tratta di cogliere qualche
somiglianza superficiale o particolare, ma di condensare in un’immagine
figurativa l’idea dell’opera originaria: «L’idea,
cioè, dell’aspetto delle cose o della combinazione di oggetti che potesse, per
sua latente virtù, mostrare una connessione con qualcosa del libro, ma che allo
stesso tempo, affermasse la propria strana e interessante individualità».
Fotografia e letteratura formano in tal caso due serie parallele, ma non
corrispondenti: le immagini fotografiche sarebbero «espressioni
non d’una particolare cosa del testo, ma solo del tipo o dell’idea di questa o quella cosa»
[3]
.
Non troppo diverso – si
potrebbe aggiungere – è il rapporto fra un saggio critico e le opere a cui si riferisce, benché in tal caso il medium
linguistico resti lo stesso. In effetti il saggio non
è mera illustrazione o descrizione dell’originale; però si riferisce
costantemente ad esso, o altrimenti diventerebbe una vuota divagazione. Esso
cerca di evidenziare alcuni significati del testo, di disporli in modo inedito secondo una interpretazione possibile, senza
negare che ve ne possano essere altre, latenti e possibili. Il
saggio è una scrittura autonoma, perché realizza, per così dire, un
montaggio significativo degli elementi che compongono l’originale; ma proprio
in tal modo permette una continuazione vivente dell’opera e appartiene alla sua
“tradizione”. Grazie all’interpretazione, il testo vive una seconda vita,
attualizza il suo senso, o addirittura – come pensavano i romantici
tedeschi – si eleva a una ulteriore e imprevista
intensità.
Nel caso di film che si riferiscano a un romanzo, incontriamo talvolta una intensità e
originalità interpretativa simili a quelle del saggio; e – allo stesso
tempo – un rapporto tra i due linguaggi (paralleli e discordi) paragonabile
a quello che esiste – secondo James – tra fotografia e letteratura.
Il film interpreta, nel senso forte
cui abbiamo accennato, il romanzo e, al di là di esso,
in qualche caso, anche l’epoca a cui appartiene o quella da esso descritta
[4]
.
[…]
FUTURO ANTERIORE
FRAMMENTI SU NON È UN PAESE PER VECCHI
Vito M. Bonito
Non
è un paese per vecchi (No Country for Old Men,
2005) di Cormac McCarthy
Non è un paese per vecchi (No Country for Old Men,
2007) di Joel ed Ethan Coen
L’uomo è mortale. E dunque l’uomo
muore. Eppure non basta, perché tale considerazione ne impone un’altra: l’uomo
è datore di morte.
Un criminale, un assassino, non è
un concetto astratto. Opera nel pensiero e nel mondo. Entra in una risonanza
così stretta con la vittima da corrispondere, luminosamente e al tempo stesso
oscuramente, al suo gioco, alla sua stessa presenza di vittima. L’assassino
dona alla sua vittima quella morte a cui egli stesso va incontro. Benefattore e
beneficato, l’assassino condivide la condizione ontologica dell’essere umano,
vittima per eccellenza. Il motivo per cui la vittima viene uccisa sta nell’essere stesso dell’assassino. La vittima e l’assassino si danno
ragione, narrano l’uno all’altro che quando il mondo arriva a coincidere con il
male allora il mondo è perfetto, ed è ora che la Fine cominci.
Siamo in un’America lasciata
incustodita e in balìa di trafficanti di droga e
criminali d’ogni specie; in un paese alla deriva in cui l’umanità ha
abbandonato ogni ordine e ogni frontiera (geografica e identitaria).
Il romanzo di McCarthy Non è un paese per vecchi e il film dei fratelli Coen disegnano l’indicibile spalancarsi del Male di cui il mondo è fatto e di
conseguenza ci mette di fronte alla consapevolezza lucida e rassegnata
dell’inizio della Fine, alla venuta dell’“angelo sterminatore” che opera nel
mondo e nel pensiero con neutralità assoluta.
La semplice quanto intransitabile
realtà oramai non è più a portata di mano se non nella verità rivelata
dell’Apocalisse. Verità che pareggia sempre i conti – tra chi è salvato e
chi viene cancellato, tra vittima ed esecutore, tra
colpa ed espiazione, tra disordine e ordine: Anton Chigurh,
l’esecutore impassibile, si muove secondo un’etica fredda, portando a termine,
in una sorta di meccanicità incomprensibile, ogni segmento della sua missione
– in una distanza senza passato e senza futuro che asseconda solo la
“normalità” di uno schema, di una norma, inderogabile, senza alterazione, a cui
tener fede.
[…]
[1]
Il progetto Oz, appena conclusosi,
è un lungo percorso di Fanny & Alexander lungo la strada di mattoni gialli
di quella che forse è la più famosa storia per bambini di tutta la letteratura
americana. Questo “viaggio teatrale” è iniziato nel 2007, e ha dato vita a nove
spettacoli (Dorothy. Sconcerto per Oz, Kansas, Emerald City, East, North, South, West, There’s no place like home, Him) e al libro O/Z,
Atlante di un viaggio teatrale (Ubulibri, 2010).
[2]
Spesso la nuova arte cercava di legittimarsi ricorrendo alle trame dei grandi romanzi dell’800. Cfr. G. Tinazzi, La scrittura e lo sguardo, Marsilio,
Venezia 2010. Le fotografie di cui parla James sono quelle di Alvin Langdon Coburn, che dovevano essere riprodotte nei frontespizi
dell’edizione londinese delle opere dello scrittore.
[3]
H. James, La coppa d’oro, Rizzoli,
Milano 2007, pp. 53-55.
[4]
Ricordo solo, a questo proposito, esempi magistrali come il Barry Lyndondi Kubrik o Il
Gattopardo di Visconti, in cui s’intersecano l’epoca di cui parla la trama, quella dello scrittore e quella del regista.
Sento ripetere spesso una battuta, secondo cui buoni film possono provenire da
mediocri romanzi, mentre è difficile che accada il contrario. Spesso è così, ma
vi sono eccezioni importanti: quando il film inscrive nel suo linguaggio
l’atteggiamento interpretativo del saggio. Come può esistere un rapporto tra cinema e pittura, cinema e teatro, cinema e filosofia,
etc. pur sempre nel segno di una differenza ineliminabile, così esiste una
relazione analoga e possibile tra cinema e critica.
|
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -
