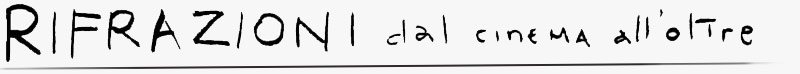
DOSSIER ESTREMORIENTE
ESTREMORIENTE
Jonny Costantino
Vedendo una lepre dite che è
graziosa,
vedendo un leone dite che è
terrificante.
Ma ignorate a qual punto si amino
nelle notti tempestose, tra rivoli
di sangue.
Mishima Yukio, Madame De Sade (1965)
La
carne è l’arena del sacro. Non del sacro istituzionale. Per quello ci sono le
religioni strutturate, codificate. Del sacro in terra, vissuto fino alla
feccia. Il sacro inteso quale sbalzo di
stato: dal tiepido esistere al vivere ardendo, dal prosaico incedere tra le
difficoltà del tirare avanti al lirico involo sopra di esse. Letto del
quotidiano straripato dalla piena del sangue. Brace del proibito e del
pericolo, del segreto e della vertigine. Del mistero, della rivelazione che non
ha parole. Lacerazione della membrana tra fisico e spirituale. Febbre del qui e
ora, non riverbero dell’aldilà. Prova belluina, la va solo se la spacca, non
miraggio di pace. Teatro del timore e del tremore. Radura angelica e verminosa
di elevazione e schianto, riscatto e dissipazione.
Il
credo animistico del Giappone antico è rinvenibile nell’espressività di un
fallo o di una vulva. Gli organi sessuali, quelli femminili in particolare,
erano venerati come oggetti sacri. Si riteneva ospitassero il potere del Buddha
e la saggezza enigmatica della dea della pietà (Kuan Yin) attraverso la quale
il Buddha si manifesta. Di conseguenza nelle shunga – le stampe erotiche giapponesi (da shun, primavera, e ga, pittura) – il sesso maschile veniva rappresentato in
dimensioni abnormi, giganteggiante. Era un eccesso funzionale ai significati
profondi veicolati da quelle stampe: una raffigurazione verosimile avrebbe
depotenziato l’effetto comunicativo e smussato la forza caricaturale
dell’immagine. Grandi artisti si sono misurati con questo filone, in primis Utamaro Kitagawa (1753-1806).
Ma l’effervescenza creativa avutasi in Giappone a partire dal IX secolo ebbe
fine nel 1873, quando la “rivoluzione imperiale” mise al bando la millenaria
arte shunga. L’organo sessuale, da
inno di carne alla vita che fiorisce, divenne osceno, tabù. Un tabù che,
giuridicamente, ancora opera nel cinema nipponico: l’articolo 175 del codice
penale vieta l’esibizione cinematografica di genitali e peli pubici (al
naturale, cioè non appannati dalle
odiose nuvolette censorie), punendo i trasgressori con pene pecuniarie e
detentive fino ai due anni di carcere. Un tabù infranto, un centinaio di anni
dopo il bando, da Oshima Nagisa. Sfruttando la “copertura” di una coproduzione
francese (la Argos Film) e il sostegno in
loco, nelle vesti di direttore di produzione, di Wakamatsu Koji
(leggendario cineasta ed ex yakuza), Oshima mostrò, per la prima volta in un
film giapponese d’autore, l’unione carnale senza veli. L’anno era il 1975 e il
film L’impero dei sensi.
Oshima affermò di aver voluto mostrare la graduale santificazione attraverso la passione degli amanti protagonisti, Sada e Kichi, che all’inizio ci vengono presantati
come due comuni libertini. Per la via dei sensi, Oshima lavora sul sacro. Un
sacro che riconduce alla carne (foss’anche la ferita nel costato del Cristo
Flagellato o la vulva da cui sfolgora pietosamente il Buddha) incrostato di
terra (perfino della terra nella bocca e negli occhi di un agonizzante),
azionando, del sacro, un pensiero e un sentimento che troviamo fluenti (in
misure pressioni profondità differenti) nei film dei quindici cineasti trattati
nel dossier “Estremoriente”. In ordine di
apparizione: Mizoguchi Kenji, Oshima Nagisa, Terayama Shuji, Imamura Shohei,
Masumura Yasuzo, Wakamatsu Koji, Matsumoto Toshio, Ishii Teruo, Chang Cheh,
Tsukamoto Shin’ya, Tsai Ming-liang, Kim Ki-duk, Miike Takashi, Park Chan-wook,
Sono Sion. Se molti di loro possono risultare sconosciuti al grande pubblico
italiano, il cinefilo più accorto avrà subito notato una dominante nipponica
(undici dei quindici sono i giapponesi) a cui si affianca un rappresentante
cinese (Chang), uno taiwanese (Tsai, malese di nascita), due sudcoreani (Kim,
Park). Il filo che unisce questi autori è una maniera personale e radicale di filmare l’umano quale terreno di
danza e contesa tra Amore e Morte. Emergerà dalla lettura dei saggi uno
scenario eterogeneo dove si possono scorgere debiti e crediti, vicinanze e
lontananze, filiazioni misconosciute e fratellanze elettive tra i singoli
cinecosmi.
[…]
IMAMURA SHOHEI THE BEAST IN HEAT
Pier Maria Bocchi
Non è chiaro da subito se il cinema di Imamura Shohei
guardi ai terreni selvaggi come sogno o come incubo. Stando a Il profondo desiderio degli dei (1968),
nell’isola di Kurage, dove primitivismo e superstizione vanno a braccetto, la
sensazione che domina è di libertà non-civile, intesa come non contaminata
dalle iperstrutture di un sistema socio-umano geograficamente poco distante
(Tokyo) ma comunque lontano anni luce; l’ingegnere della terraferma che giunge
in loco alla ricerca di acqua per la raffineria di zucchero disturba i rapporti
e inquina gli animi, tanto che alla fine il luogo diventa inevitabilmente meta
turistica. Eppure La ballata di Narayama (1983), che del film di quindici anni prima sembra un remake, un reboot, una
rielaborazione più oscura, non prevede certo l’elegia per un mondo impavido e
selvatico, bestiale e elementare, nel quale si giustiziano i ladri di patate
buttandoli legati in un pozzo e i vecchi vanno a morire tra gli dei e i corvi.
Le origini per Imamura non sono soltanto e banalmente un’idea per la conoscenza
del moderno, un posto da cui attingere per capire l’odierno: gli universi fermi
nel tempo di Il profondo desiderio degli
dei e La ballata di Narayama non
appartengono al passato ma esistono nel presente, paralleli anche se non visti
e non sentiti, verosimilmente presenti anche se assenti, vivi anche se sporchi e rozzi e come morti. Quindi per
Imamura ci sono due esistenze, due realtà, due differenti gradi di intesa tra
uomo e natura; nessuno esclude l’altro, ma anzi uno implica l’altro da sé, ne
sottende identità e regole, trucco e strucco, abito e nudità per due diverse
espressioni del rapporto fra persona e cose.
Non c’è dunque uno scarto di merito temporale e
culturale nei film di Imamura, non esiste un’epoca lontana degna di essere
ripensata e rivissuta e una contemporaneità peggiore perché industrializzata e
in rovina. Nel suo cinema ogni corpo e ogni idea di mondo vivono simmetrici
anche quando non in sintonia; ogni attitudine, comportamento, azione vengono
giustificate e assolte in sé e nel sé esclusivo, mentre Dio o gli dei stanno a
guardare. La civiltà comunemente intesa perde di senso e di valore, per
Imamura; a sostituirla è un complesso di segni, costumi e usanze che si
autogiustifica con la pratica prolungata, con la tradizione del suo esercizio.
Che si tratti allora del disboscamento per la costruzione di una pista per
l’atterraggio degli aerei (Il profondo
desiderio degli dei) o della sodomia di un cane come unico sfogo per il
rifiuto generale (La ballata di Narayama),
non c’è vera differenza: sono entrambe manifestazioni di un vivere che rispetta
esclusivamente la propria urgenza, e in essa trova la ragione indiscutibile.
Progresso e animalesco, dunque, sono facce della stessa medaglia, che Imamura
non condanna. Allo stesso modo, egli si guarda bene dal puntare l’indice contro
le cosiddette perversioni dell’agire e del pensare umani. Amore e morte, sesso
e sangue rappresentano un vocabolario insostituibile, sono termini che
s’intrecciano e non si abbandonano, parole crociate che non s’escludono;
Imamura, nel frattempo, non osa impedirne o censurarne nessuna, perché sa che
metterle al bando significherebbe deprezzarle e quindi motivare le separazioni
le classi i gradi le discordie le guerre: «soprattutto amo la sua idea che
tutta la vera saggezza giapponese è nel popolo basso che non viene
rappresentato, che il vero coraggio è nelle persone condannate dalla società.
In questo lo trovo molto commovente, proprio perché non è una presa di
posizione politica, ma un’adesione viscerale, un discorso estremamente anarchico,
contro tutte le forme di autorità ma anche contro tutti i partiti organizzati» (Paulo Rocha). Nel cinema di Imamura Shohei
non esiste dissenso, non ci sono reparti di vita o di società, un padre che si
offre con la figlia malata di mente per una parte in un quickie pornografico (Introduzione
all’antropologia, 1966) ha lo stesso peso sociale – e, per il
regista, la stessa moralità –
di una ragazza che con coraggio inaudito rifiuta di cedere al ruolo femminile
post-bellico di oggetto sessuale e di servitrice del maschio padrone e
colonizzatore, e scandalosamente fa le valigie per abbandonare tutto e tutti
recandosi alla stazione ferroviaria (Porci,
geishe e marinai, 1961). La bassezza possiede il medesimo diritto
d’esistere e di attuarsi della virtù e della bontà, perdendone i connotati
etici e diventando, per dirla con Rocha, anarchia e lotta contro il potere
costituito. Non c’è critica, non c’è biasimo: il turpe nei film di Imamura non
serve a rimarcare il suo contrario, bensì a capire che l’educazione dell’uomo,
la sua socialità, è un tratto identificativo come un altro, depurato di ogni
morale comune. La sopravvivenza e l’armonia passano anche attraverso
l’omicidio, programmato e accettato dalla comunità: il villaggio tra le
montagne di La ballata di Narayama campa con poco, e se c’è una bocca da sfamare in più è un problema.
[…]
COMUNITÀ DELLA CARNE E POSSESSIONE MISTICA AMORE E MORTE NEL CINEMA DI SONO SION
Matteo
Boscarol
Ho voluto saturare la visualità di
ogni scena
con quanti più dettagli possibile.
Volevo che tutto fosse erotico e
sanguinoso.
Sono Sion
C’est par la barbaque
la sale barbaque
que l’on exprime.
Antonin Artaud
La
scena iniziale è quella del film che ha reso celebre Sono Sion al pubblico
internazionale, Suicide Club. Le
giovani studentesse mano nella mano sul ciglio del binario pronte a gettarsi
insieme all'arrivo del treno. La purezza delle ragazzine, le loro divise
scolastiche e il loro chiacchierare come se niente fosse, gli sguardi felici,
sbarazzini ed il fatto che si tengano mano nella mano in un periodo della vita
così intenso e difficile stride con il salto mortale che compieranno all'unisono, lo
spettatore non è preparato ad un inizio tanto scenografico quanto scioccante.
Allo stesso tempo però tutta questa leggerezza e questo amore trova nel
suicidio di gruppo e nel successivo profluvio eccessivo di sangue che ne
consegue il suo coronamento. Una comunità amorosa, il legame di amicizia
che lega le studentesse delle scuole superiori sfiora e lambisce spesso l’amore
saffico, che in una società senza speranza trova il proprio senso e la propria
celebrazione solo nella comune distruzione della vita, nell’annientamento del
corpo vivente e nell’unione finalmente realizzata nello scorrere comune del
sangue. Isolato dal contesto narrativo che lo segue, l’inizio del film in pochi
secondi ci rivela molto di quelle che sono la poetica e le tematiche che
plasmano l’opus cinematografico del regista. Un approccio per certi versi non
dissimile da quello del già citato Ishii Teruo, maestro dei b-movie e di quel
filone cinematografico dell’ero-guro che fra la fine degli anni Sessanta
ed i primi Settanta raggiunge il suo apice con opere quali The Joy of Torture e Horror
of The Malformed Man. Questo gusto per l’eccesso e per la mescolanza fra
erotismo (anche di bassa lega) e violenza è presente in quasi tutta l'opera di
Sono, naturalmente in diverse gradazioni, fin dai primi esperimenti di I Am Sion Sono! (Ore wa Sono Shion da!!, 1985) o nel recente Guitly of Romance (Koi no
tsumi, 2011) e che trova la sua massima espressione nel delirante Strange Circus (Kimio na saakasu). I Am Sion
Sono! è il cortometraggio girato in 8mm con cui Sono debutta dietro (ma
anche davanti) alla macchina da presa, un caotico accumulo di situazioni quasi
amatoriali, dove il protagonista è appunto quasi sempre il regista stesso.
Anche in un’opera così acerba però, si possono cogliere in fase embrionale molti
degli stilemi che caratterizzeranno il proseguio della sua carriera, per il
discorso che a noi qui interessa sono da notare particolarmente due scene.
Nella prima vediamo Sono in primo piano gridare simulando orgasmi mentre un
amico gli taglia i capelli con un rasoio elettrico; in un’altra scena lo
vediamo simulare dei rapporti sessuali con delle statue di gesso, ma il sesso
simulato delle grida orgasmiche si tramuta subito in urla di dolore dal sapore
quasi artaudiano e ancora vedremo le statue e Sono stesso ricoperti di sangue.
Sesso come simulazione, attrazione per l’inorganico, amalgatofilia, gioia che
si tramuta in dolore ed il rosso del sangue usato in modo quasi espressionista,
questo è il percorso che simbolicamente l'autore traccia profeticamente in
questa sua opera prima. Una linea estetica che verrà ripresa, sviluppata ed
amplificata fino al parossismo in Strange
Circus. I primi minuti del film ci fiondano direttamente in quel
lago di sangue scarlatto che è il film, siamo in un circo, la grassa drag queen
sul palco invita qualcuno fra il pubblico a provare la ghigliottina, si fa
avanti una bambina dodicenne ma quando sta per essere giustiziata si sveglia
dall’incubo. A questo punto però sente dei gemiti provire dalla camera da letto
dei genitori, vi si reca e li scopre durante un rapporto sessuale. Il giorno
dopo il padre la chiama nel suo uffico, abusa di lei e dopo alcuni giorni la
rinchiude nella custodia di un violoncello dopo aver praticato un buco per
permetterle/obbligarla ad assistere ad un altro rapporto sessuale fra lui e la
madre. Seguendo la filosofia di uno dei suoi mentori, il regista e teatrante
Terayama Shūji, secondo la quale nell'arte non ci dovrebbero essere tabù
di alcun tipo, Sono riversa in questa opera tutti gli incubi che animano la
parte oscura dell'essere umano. Sesso violento, incesto, pedofilia e un vento
malvagio che accarezza tutto il film, si mescolano in questo terribile sogno
circolare completamente dominato dal colore rosso. Il sangue che esce dalle
ferite e quello mestruale sembra qui fuoriuscire all’esterno e inondare il
mondo del film, è l'interno purpureo dei corpi che sono gli esseri umani che si
estroietta nella pellicola, un rosso che satura la visione come nella stupenda
scena in cui la bambina percorre un corridoio le cui pareti sono completamente
ricoperte di sangue. In questo senso l’atto sessuale, e per derivazione anche
l'amore, sembra solo un pretesto per far uscire più sangue e più dolore.
[…]
|
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -



